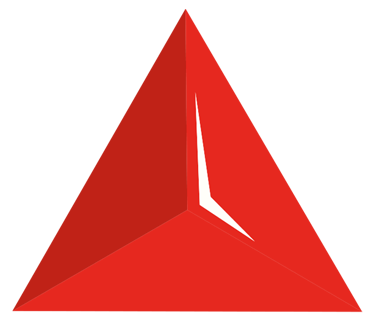Circolo ripetitore di Amici
Descrizione: Questo doppio circolo ripetitore in altezza e azimut fu ideato e costruito da Giovan Battista Amici (1786-1863) , pur essendo simile a quelli dal costruttore francese Henry Prudence Gambey (1787-1847) presenta alcune particolarità originali.
Il sistema a ripetizione, ideato dall’astronomo e cartografo tedesco Tobias Mayer (1723-1762) consiste nel ripetere la misura di un’angolo numerose volte modificando opportunamente la posizione dei cerchi e sommando ogni volta il valore ottenuto. Alla fine il risultato viene diviso per il numero di ripetizioni eseguite; ciò permette (almeno teoricamente) di dividere anche l’errore medio per il numero di ripetizioni.
Lo strumento, tutto in ottone, è montato su di una colonna tronco-conica posta su di un tripode munito di viti calanti. Nel tripode è infilato il perno che con un collare a sei bracci sostiene il cerchio orizzontale recante due nonii muniti di diffusori di luce di carta traslucida. Concentricamente ad esso vi è una corona circolare, di costruzione analoga al cerchio e recante una scala d’argento. La scala, da 0° a 360°, è divisa in 10′. I nonii permettono delle letture a 10” che avvengono tramite una coppia di lenti fissate ad un’asta imperniata sulla sommità dell’asse verticale. Tramite ganasce munite di viti micrometriche è possibile fissare o variare lentamente le posizioni del cerchio e della corona graduata. Sul cerchio sono avvitati i sostegni dell’asse del cannocchiale. Questo reca da un lato una coppia di cerchi verticali del tutto analoghi a quelli orizzontali e, dall’altro, un contrappeso cilindrico munito di livella a bolla. Due ganasce permettono di fissare sia la posizione relativa dei cerchi che la loro posizione rispetto allo strumento e una coppia di lenti permette le letture della scala e dei nonii. Il peso sostenuto dall’asse orizzontale è ripartito sul sostegno grazie ad una molla a balestra. A cavallo di questo asse è posato una seconda livella a bolla che permette di assicurarne l’orizzontalità. Il cannocchiale acromatico e astronomico (apertura 35 mm) è fissato sul cerchio verticale interno solidale con l’asse. Reca un oculare di tipo Huygens munito di reticolo di fili e scorrevole telescopicamente guidato da un’apposita scanalatura.
Presso l’obbiettivo vi sono due fori circolari diametrali allineati perpendicolarmente all’asse ottico. I fori erano in origine chiusi da lastrine di vetro (oggi scomparse) recanti un segno di riferimento che fungeva da mira. Un braccio, la cui posizione può essere variata tramite una vite senza fine e una corona circolare dentata, è fissato concentricamente sull’ asse orizzontale e reca un piccolo microscopio (mancante delle lenti). Il suo asse ottico è posto perpendicolarmente a quello del cannocchiale e regolando la posizione del braccio di sostegno viene fatto coincidere con la mira di vetro.
L’Amici sosteneva che una delle cause di imprecisione nell’eseguire misure seguendo un astro (e cioè un corpo in movimento) erano date dal fatto che, dovendo operare rapidamente, non era possibile lasciare assestare perfettamente la bolla della livella del cannocchiale che, fra una ripetizione e l’altra, doveva essere riportato in posizione orizzontale. L’introduzione del microscopio e della relativa mira in vetro avrebbe dovuto ovviare a questo inconveniente. Infatti, compiendo la prima misura, dopo aver mirato l’astro con il cannocchiale, era necessario far collimare il microscopio con la mira in vetro posta nel tubo. In questo modo, dopo aver riportato il cannocchiale orizzontalmente si sarebbe potuto compiere la seconda misura, non mirando ancora l’astro (nel frattempo mossosi in una nuova posizione) ma facendo collimare di nuovo l’asse ottico del microscopio con la mira. Secondo l’Amici, grazie a questo ingenuo artificio, le misure avrebbero potuto essere ripetute senza fretta, con un’accurato assestamento della livella. In realtà oltre ad altri svantaggi di questo sistema, l’Amici non considerava il fatto che, se la prima misura era errata, anche le seguenti avrebbero contenuto invariabilmente lo stesso errore, annullando così uno dei principali vantaggi del metodo di ripetizione.
Lo strumento veniva usato senza l’ausilio del microscopio nel determinare angoli sottesi da punti terrestri fissi. E’ protetto da una vetrina.
Data: 2/4 XIX sec.
Autore: non è firmato ma fu costruito da Giovan Battista Amici
Misure: Larghezza 470, profondità 450, altezza 390; vetrina: 520x520x540 mm