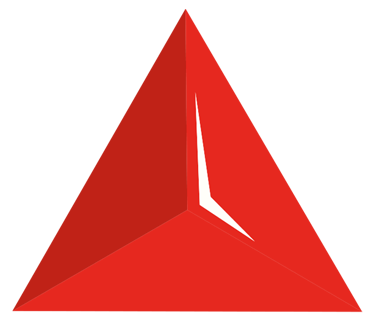Freno elettromagnetico Pasqualini (modello A)
Descrizione: Il freno elettromagnetico, ideato nel 1892 dall’ingegnere italiano Luigi Pasqualini (1859-1943), rappresenta un’applicazione pratica dei fenomeni dovuti alle correnti di Foucault. Esso funziona in effetti con lo stesso principio dello strumento con n° inv.620 e viene utilizzato come freno dinamometrico per misurare la potenza sviluppata da un motore. Il modello A qui illustrato è adatto a motori sviluppanti fino a 1 cavallo-vapore.
In una base di ghisa verniciata sono inserite tre viti verticali di ottone nichelato. Su di esse, tramite anelli filettati, è fissato un sostegno munito di due bracci laterali e, centralmente, di un coltello d’acciaio. Sul coltello è posato in equilibrio un telaio quadrangolare di metallo nichelato e verniciato, al centro del quale si trovano due grossi elettromagneti cilindrici e paralleli con anima in ferro. Essi sono collegati in serie e i loro capi terminano ad una coppia di serrafili fissati su di una piastra in fibra. La piastra del telaio di fronte agli elettromagneti reca un cuneo metallico amovibile e la sua distanza dagli elettromagneti può essere variata tramite quattro bulloni. Il telaio più oscillare sul coltello e l’ampiezza del suo movimento è limitata da una coppia di viti imperniate verticalmente nei bracci del sostegno. Su due lati opposti del telaio sono fissati due bracci quadrangolari sui quali è incisa una scala millimetrata lunga 40 cm. Una livella a bolla permette di verificare l’orizzontalità del telaio e una sfera metallica inserita fra due anelli filettati su di un’asta verticale funge da contrappeso regolabile. Su di una piastra metallica si trova la scritta «FRENO ELETTROMAGNETICO PASQUALINI MOD.A.».
L’apparecchio è munito dei seguenti accessori:
a) un disco (15 cm di diametro) composto da una spessa lastra di rame e da una di ferro più sottile fissata ad essa recanti un asse munito di puleggia e di manicotto di bronzo. La lastra di ferro giustapposta a quella di rame permette di compensare l’azione del campo magnetico lungo l’asse del disco;
b) disco di rame e ferro di diametro più grande (diametro 19 cm);
c) tre contrappesi di ferro di peso diverso e di forma ellittica muniti di foro con ganascia e vite di fissaggio da infilare sui bracci dello strumento. Uno è il peso di equilibrio e reca la scritta 00, gli altri sono marcati: «W2 9» e «W1 10».
Il manicotto recante un disco di rame viene fissato sull’asse del motore di cui si desidera misurare la potenza. Esso viene poi inserito nel telaio (estraendone il cuneo mobile) in modo tale che il disco venga a trovarsi adiacente agli elettromagneti. La puleggia viene collegata tramite una cinghia di trasmissione ad un tachimetro. Uno dei pesi W viene posto su di un braccio nella posizione 0 della scala (il braccio sul quale si inserisce il peso di regolazione dipende ovviamente dal senso di rotazione del motore in esame) mentre il peso 00 viene inserito sull’altro braccio e fissato in modo che l’apparecchio sia in equilibrio. Azionando il motore e attivando gli elettromagneti (con una corrente massima di circa 5-6 ampère a 100-120 volt) nel disco si formano delle correnti di Foucault e per il loro effetto gli elettromagneti tendono a inclinarsi nella direzione del senso di rotazione del disco stesso. Si ristabilisce l’equilibrio e si riporta il telaio in posizione orizzontale spostando il peso W lungo il braccio. Modificando la posizione del contrappeso sferico è possibile variare la sensibilità dell’apparecchio. Dalla grandezza del peso e dalla sua posizione sul braccio graduato si stabilisce la coppia che tende a far ruotare gli elettromagneti. Questa coppia è uguale a quella sviluppata sull’albero motore. La potenza del motore si ottiene si ottiene moltiplicando la costante marcata sui pesi per il numero di giri e per lo spostamento del peso (in metri) dal punto 0 della scala.
Uno svantaggio del freno Pasqualini consiste nel fatto che, riscaldandosi notevolmente il disco di rame, non è possibile eseguire misure di lunga durata.
Data: 1908 circa
Autore: firmato dalle Officine Galileo
Misure: Larghezza 1260, profondità 350, altezza 300 mm