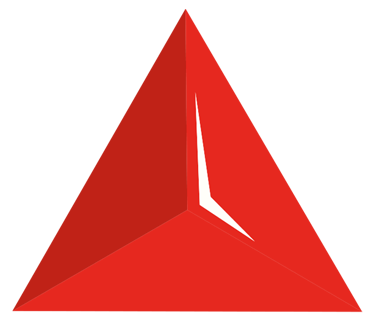Goniometro a riflessione di Webski (modello II)
Descrizione: Questo strumento, descritto nel 1879 dal mineralogista tedesco Christian Friedrich Martin Websky (1824-1886) era utilizzato essenzialmente per ricerche cristallografiche quali le misure degli angoli fra le facce di un cristallo e al tempo stesso può venire usato come spettrometro o rifrattometro. Esso rappresenta una versione perfezionata dei due apparecchi con n° inv.117 e n° inv.149.
Un treppiede munito di viti calanti sostiene un disco. Un asse verticale, passante per il suo centro, regge il portaoggetti e la sua altezza puo’ essere regolata tramite un’apposita manopola filettata. L’asse è solidale con un disco girevole, recante una corona circolare d’argento, graduata da 0° a 360°, con divisioni ogni 15′. Ruotando un’apposito anello filettato e una vite di fissaggio l’asse e il disco possono essere bloccati ad un braccio a molla. Una vite micrometrica imperniata in uno dei piedi dello strumento agisce sul braccio e permette di variare l’angolo azimutale del portaoggetti. Un asse conico, concentrico a quello descritto, reca un secondo braccio con una colonnina che sostiene il tubo nel quale inserire il cannocchiale di osservazione. A detto asse è pure fissata una corona circolare che protegge la scala graduata visibile attraverso due finestrelle. Due nonii permettono le letture del cerchio graduato con una precisione di 30”. Le letture avvengono con l’ausilio di una coppia di lenti aplanatiche montate diametralmente alle estremità di un braccio girevole. Le lenti sono munite di diffusori di luce in corno e di due specchietti per l’illuminazione.
Il cannocchiale e la rispettiva corona possono compiere movimenti micrometrici grazie ad un sistema di braccio con molla di richiamo e vite del tutto simile a quello utilizzato per il disco graduato solidale con il portaoggetti. Davanti alla lente obbiettiva del cannocchiale è imperniata una lente d’ingrandimento girevole; posta in corrispondenza dell’ asse ottico trasforma il cannocchiale in un microscopio che permette di centrare il reticolo sullo spigolo del cristallo in esame.
La posizione del portaoggetti viene regolata ruotando una manopola posta sotto lo strumento e viene fissata stringendo un anello concentrico all’ asse portante. Il portaoggetti possiede 4 gradi di libertà: due slitte piane munite di viti micrometriche permettono movimenti orizzontali e ortogonali fra loro; fissate ad esse due slitte arcuate, pure munite di viti micrometriche, consentono rotazioni di circa + 40° secondo due assi perpendicolari. Il piattello inserito sul portaoggetti può essere asportato.
Il collimatore è montato su di un’asta fissata ad uno dei piedi dello strumento tramite viti di regolazione. Si compone di un tubo con una lente acromatica nel quale vengono inseriti i diversi traguardi.
Lo strumento è corredato da un astuccio contenente i seguenti accessori:
a) 4 tubi con traguardi diversi da inserire sul collimatore.
I traguardi, tutti montati su di un tubo d’ottone, si infilano sul collimatore sempre con lo stesso orientamento grazie ad un dente triangolare che si inserisce in un apposita tacca.
a.1) Traguardo ideato da Websky. E’ composto da una fessura delimitata da due dischi dal bordo affilato la cui distanza è regolabile a vite. Viene utilizzato per misure goniometriche.
a.2) Traguardo formato da una fenditura rettilinea la cui larghezza è regolabile a vite. Viene usato per misure spettrometriche e per determinare gli indici di rifrazione.
a.3) Traguardo ideato dal mineralogista tedesco Albrecht Schrauf (1837-1897). E’ formato da un disco di vetro argentato recante due fenditure perpendicolari. Nel loro punto d’incontro si incrocia un reticolo di fili. Viene utilizzato specialmente per tarare lo strumento. (Questo traguardo è protetto da un coperchietto).
a.4) Traguardo con un’apertura circolare (diametro circa 0,5 mm). Viene utilizzato per osservare i riflessi delle facce vicinali di un cristallo.
b) Un tubo, munito di lente convergente, da inserirsi sul traguardo utilizzato. La lente permette di illuminare intensamente il traguardo, concentrandovi la luce proveniente da una lampada.
c) Un prisma di Nicol da inserirsi nel tubo b). L’alloggiamento cilindrico del nicol reca le marche di 0°, 45° e 90°. Con il suo ausilio è possibile determinare gli indici di rifrazione dei cristalli birifrangenti nonchè i relativi rapporti di polarizzazione.
d) Quattro diversi oculari, montati in appositi tubi nichelati muniti di reticoli di fili rettificabili a vite, da inserirsi nel cannocchiale.
d.1) Un oculare formato da una lente semplice. Si utilizza accoppiato ad una seconda lente da inserire davanti all’obbiettivo del telescopio dopo aver tolto la lente girevole dall’ asse ottico del sistema. Questo accorgimento riduce della metà l’immagine del traguardo e permette di osservare i riflessi di piccole superfici visibili solo con una lente d’ingrandimento.
d.2) Oculare di Ramsden (ingrandimento circa x 3).
d.3) Oculare di Ramsden (ingrandimento circa x 6). Viene usato specialmente quando si compiono misure molto precise o quando si calibra lo strumento.
d.4) Oculare di Huygens (ingrandimento circa x 2).
e) Ghiera con lente d’ingrandimento che viene utilizzata sul telescopio in combinazione con l’oculare d.1).
f) Un tubetto d’ottone chiuso da un diaframma circolare forato che può essere occultato da un secondo diaframma girevole con un foro di diametro inferiore al primo.
g) Una chiave a tubo che permette di stringere o allentare il piccolo anello di fissaggio che si trova sotto il portaoggetti.
Data: 1885 circa
Autore: firmato da Rudolf Fuess
Misure: Altezza: 260, larghezza max. (senza oculari): 320; astuccio: larghezza 350, profondità 155, altezza 55 mm